25 Novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
In questi giorni, mentre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne attira lo sguardo di tutti, il dibattito pubblico si riempie di parole che, a forza di essere ripetute, finiscono per perdere spessore.
Si parla di femminicidio come se fosse un concetto semplice, lineare, privo di stratificazioni, un’etichetta da applicare a qualunque donna perda la vita per mano di qualcuno, senza considerare ciò che davvero è avvenuto prima, durante e dentro quella relazione.
Proprio per questo sento che questo è il momento giusto per rimettere ordine, per dire con chiarezza qualcosa che raramente trova spazio: non per provocare, ma per restituire complessità a un tema che la merita e che, se compreso, può cambiare il modo in cui riconosciamo, preveniamo e interpretiamo la violenza.
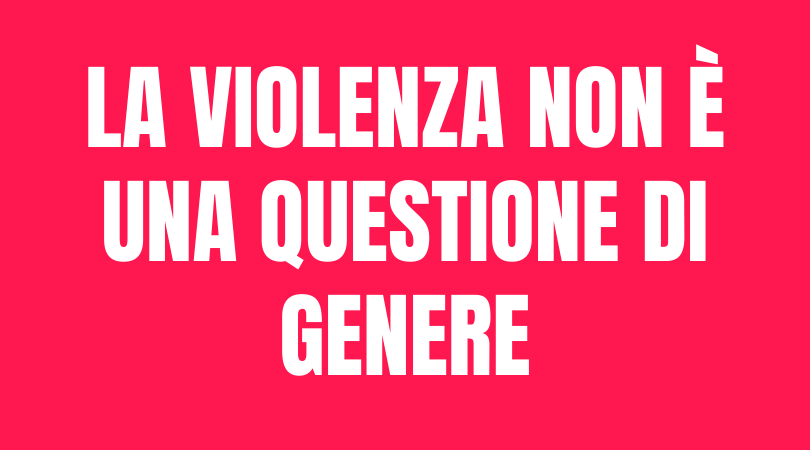
Le donne non vengono ammazzate perché sono donne.
Non è il corpo femminile a determinare il destino della violenza. Non è l’anatomia, non è la biologia, non è il fatto di avere una vagina. Insistere su questa narrazione significa cercare la causa dove non si trova e distogliere lo sguardo da ciò che, invece, avremmo davvero la possibilità di prevenire.
La violenza prende forma nella struttura della relazione e, ancora più radicalmente, nella struttura della personalità di chi esercita dominio, e dal suo funzionamento disturbato.
Nasce da un assetto interno in cui l’altro non viene percepito come soggetto autonomo, dotato di una mente, di un desiderio, di una libertà, ma come un oggetto regolatore: un serbatoio di stabilità narcisistica, di conferme, di identità e di controllo.
Chi ha questo funzionamento non vede l’altro come essere umano. Fin dall’inizio, la relazione non è un incontro tra due autonomie, ma un sistema chiuso e asimmetrico, in cui la libertà di una persona è tollerabile solo finché non contrasta con il bisogno dell’altra di dominare.
È dentro queste personalità spesso caratterizzate da tratti narcisistici gravi, da un’assenza strutturale di empatia, da componenti psicopatiche o antisociali, che germogliano le dinamiche capaci di condurre, passo dopo passo, al gesto estremo di togliere la vita a qualcuno.
Quando chi ha questo funzionamento percepisce che la propria “fonte” sta sfuggendo al proprio controllo, non vive la distanza come una separazione fisiologica, ma come un collasso identitario. Il rifiuto diventa uno schiaffo narcisistico. La separazione diventa una minaccia esistenziale. La libertà dell’altro diventa un inesigibile tradimento dell’ordine interno.
E così si arriva a togliere la vita non perché l’altro appartiene a un certo genere, ma perché tenta di esistere fuori dal raggio del suo controllo.
Ed è proprio per questo che le stesse identiche dinamiche possono manifestarsi anche in assenza totale di donne, o in assenza totale di uomini.
Lo vediamo con estrema chiarezza nelle relazioni tra due uomini, quando uno dei due esercita un controllo totalizzante, vive il partner come un’estensione della propria stabilità interna e reagisce alla separazione con lo stesso tipo di escalation osservata nelle coppie eterosessuali. Lo vediamo nelle relazioni tra due donne, quando la simbiosi patologica, la gelosia coercitiva o l’incapacità di percepire l’altra come identità separata generano lo stesso copione distruttivo. E poi lo osserviamo nelle relazioni eterosessuali in cui è chi agisce violenza ad avere un corpo femminile: perché ciò che guida il gesto non è il genere, ma l’impossibilità psicologica di tollerare l’autonomia dell’altro.
Quando guardiamo i dati e scopriamo che sono soprattutto le donne a perdere la vita nelle relazioni eterosessuali, rischiamo di confondere una ricorrenza statistica con un movente psicologico. La statistica descrive dove un fenomeno accade più spesso, ma non spiega perché accade. Scambiare il “dove” con il “perché” significa utilizzare gli strumenti della sociologia per tentare di risolvere un enigma che è, necessariamente, anche psicologico: significa scambiare la cornice per il quadro.
Ed è qui che emerge un altro grande equivoco culturale: l’idea che il patriarcato, come struttura astratta, sia il motore diretto della violenza estrema nelle relazioni. Il patriarcato esiste, plasma ruoli, aspettative e distribuzione del potere, e crea un terreno fertile per certe dinamiche. Ma non è la leva interna del gesto. Pensare che tutto dipenda dal patriarcato è in parte rassicurante perché sposta il male altrove, al di fuori della psiche individuale, evitando il confronto con una verità più angosciante: esistono personalità che non tollerano la libertà dell’altro indipendentemente dal contesto culturale in cui vivono.
È molto più semplice dire “la causa è un sistema” che ammettere che alcune persone non concepiscono l’altro come un soggetto. Il patriarcato, in questo senso, è simile a un fondale teatrale: prepara l’atmosfera, ma non muove gli attori. Non è il patriarcato ad affondare la lama, a strangolare, a sparare. A farlo è una persona in carne ed ossa. Se continuiamo a guardare la violenza da lontano — dalle statistiche, dalle ideologie, dalle strutture sociali — continueremo a perdere ciò che accade da vicino: la formazione di una relazione patologica.
Ed è invece proprio lì che dovremmo spostare lo sguardo se vogliamo davvero prevenire: non sul genere della vittima, ma sulla qualità del legame; non sulla biologia, ma sulla dinamica; non sulla frequenza, ma sulla trama psicologica.
Perché molto prima che qualcuno arrivi a togliere la vita, c’è sempre una storia che racconta come ci si è arrivati: una storia fatta di controllo crescente, di confini che si assottigliano, di identità che si mescolano fino a confondersi, di svalutazioni normalizzate, di isolamento travestito da protezione, di manipolazione emotiva che diventa linguaggio, di piccoli cedimenti che sembrano minuscoli e invece preparano il terreno al resto.
Questa storia non ha genere. Ha struttura. E quella struttura è sorprendentemente invariabile. Per questo, oggi più che mai, mentre il mondo parla di violenza sulle donne correndo il rischio, anche senza volerlo, di appiattire tutto in una guerra tra generi, sento fondamentale richiamare il punto essenziale: chi non tollera il limite dell’altro è pericoloso, qualunque sia il suo genere e qualunque sia il genere del partner. E chi tenta di uscire da una relazione segnata da questo funzionamento rischia, indipendentemente dal proprio corpo.
E allora la domanda che dovremmo farci non è più “Perché gli uomini uccidono le donne?”, ma “Perché alcune persone — uomini o donne, in relazioni etero o omosessuali — non sopportano la libertà dell’altro?”.
Lì sta il cuore del problema. Lì si trovano il rischio e la possibilità di prevenzione. Lì si gioca la differenza tra leggere la violenza come una questione di genere o come una questione psicologica, che è l’unica prospettiva in grado di anticipare, riconoscere e proteggere. Se vogliamo fare un passo avanti come società, dobbiamo superare l’idea che il patriarcato sia l’origine unica e totalizzante di ogni violenza. La violenza estrema diventa possibile quando qualcuno — indipendentemente dal tempo, dal contesto o dalla cultura — non ha mai saputo concepire l’altro come un essere libero.
Le donne non vengono ammazzate perché sono donne; gli uomini non vengono risparmiati perché sono uomini.
La violenza non sceglie in base ai corpi: sceglie in base ai legami. E chi conosce la psicologia delle relazioni patologiche sa che ogni legame racconta un modo di concepire l’altro, un modo di trattare la libertà altrui, un modo di gestire — o di non gestire — la perdita. È in quel modo di concepire l’altro che si gioca tutto.
Quando una persona sviluppa un funzionamento tale da non riuscire a immaginare l’altro come separato, la relazione smette di essere un incontro e diventa una struttura di dipendenza unilaterale, una stanza senza uscite dove la libertà dell’altro non è solo difficile da accettare, ma è intrinsecamente percepita come un sabotaggio.
Questo non ha a che vedere con il genere, ma con l’organizzazione di personalità.
Per questo, continuare a leggere la violenza estrema unicamente attraverso la lente del genere significa rischiare di perdere il nodo del fenomeno: significa analizzare l’ombra invece dell’oggetto che la genera.
È una scorciatoia che rassicura perché offre una spiegazione semplice a qualcosa che semplice non è.
Se vogliamo prevenire, dobbiamo imparare a riconoscere quando una relazione smette di essere un incontro e diventa un sistema chiuso in cui una sola mente detta i confini e l’altra li restringe per sopravvivere.
Dobbiamo osservare quando il linguaggio diventa manipolazione, quando la cura diventa controllo, quando la gelosia diventa un mezzo e l’identità dell’altro diventa un terreno di conquista.
La prevenzione vera non sta nel dire “proteggiamo le donne”, ma nel dire “proteggiamo chiunque sia intrappolato in una relazione in cui l’autonomia dell’altro è percepita come una minaccia”.
Perché quella minaccia — nella mente di chi domina — non ha genere.
E il gesto estremo non ne avrà mai.
Quello che conta, alla fine, è la struttura del legame: se permette la libertà o se la annienta.
In quella differenza, apparentemente sottile eppure decisiva, si gioca l’intero destino di una relazione.
Ed è lì — non nella biologia, non nei corpi, non nelle categorie ideologiche — che dovremmo guardare se vogliamo rendere davvero comprensibile ciò che accade e, soprattutto, se vogliamo impedirlo.